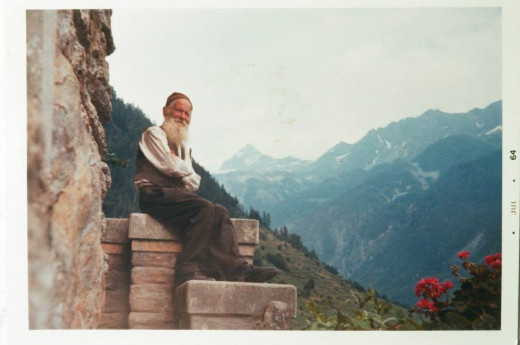Sale Marasino e i suoi borghi
Il comune di Sale Marasino conta circa 3300 abitanti, distribuiti tra i nuclei storici disposti lungo l’anfiteatro naturale prospiciente il lago d’Iseo e l’edificazione diffusa che li ha saldati nel tempo in un continuum di ville, villette, giardini, campi e uliveti, non privo di una qualche bellezza. Il panorama è ben visibile sia lungo le rive, sia salendo verso le cime e i passi che separano l’abitato e la parte montana del comune dalla Valle Trompia, come Punta Almana (1390 m) o la Forcella di Sale (1018 m). Per leggere il territorio e il paesaggio è possibile utilizzare come linea guida il percorso dell’antica strada Valeriana. Di origine alto-medievale, essa costituiva l’infrastruttura viaria degli insediamenti di mezza costa. Essa interseca i borghi principali dell’attuale comune e collega, attraverso ramificazioni del percorso principale, quelli restanti da cui si dipartivano percorsi, mulattiere, sentieri, viottoli, verso la parte alta e bassa dell’anfiteatro morenico. Da Sud a Nord, superato il torrente Mesagolo, che definisce il confine con il comune di Sulzano, si incontra Maspiano, disposto su una sorta di piccolo falsopiano, in una posizione panoramica di bellezza straordinaria che domina l’intero lago da Iseo alle Orobie e che doveva quindi costituire un ottimo punto di sorveglianza del territorio. Oggi, come nella Mappa Napoleonica del 1811, Maspiano appare chiaramente diviso in due parti separate da uno spazio aperto che vede al centro la piazza e la chiesa settecentesca di San Giacomo. Emerge il ruolo preminente dell’asse principale, ora via Maspiano (presumibilmente corrispondente alla Valeriana) e dell’incrocio tra la strada di collegamento con Gandizzano (Strada de Chepi) e quella con Marasino; è evidente dall’altro lato del paese, la brusca svolta dell’asse principale verso via Tesolo (Strada delle Scape). Risalta l’importanza dei due “colatori”, piccoli cavi adibiti al deflusso delle acque dalla montagna, oggi non più visibili e posti uno a confine, verso Sulzano (colatore della Quatera), l’altro lungo il lato nord della chiesa di San Giacomo (colatore di San Giacomo). È possibile che costituissero, con i muri perimetrali degli edifici più esterni, una sorta di rudimentale apparato difensivo. I due nuclei insediativi sono costituiti da tipologie edilizie comprendenti un edificio con la facciata principale munita di portici, talvolta colonnati, e loggiati lignei, rivolta a sud o sud-ovest, corpi edilizi accessori e alti muri di cinta in pietra che organizzano spazi aperti interni costituiti da serie di corti successive. Gli edifici fanno capo a stretti vicoli a fondo cieco, muniti di archi e porte (talvolta scomparse) o di strutture a volta. È un tessuto edilizio a vocazione agricola ma con forte carattere difensivo – accentuato nelle parti al margine dell’insediamento – testimoniato dalla presenza di feritoie nei pressi di alcuni portoni lignei, destinate ad accogliere ad archibugiate ospiti non graditi. Alcuni alti muri in pietra, coperti in parte dalla vegetazione, sono particolarmente pregevoli, così come gli alti portali e le parti edificate che hanno mantenuto i caratteri storici, senza manipolazioni recenti. A Maspiano è presente una caratteristica edificatoria che è quasi scomparsa o è stata occultata altrove: alcuni corpi edificati, disposti in serie, sono accostati lungo i muri d’ambito, ma separati da uno stretto spazio, l’ambitus, destinato alla raccolta e allo smaltimento delle acque piovane. Superata la valle del torrente Portazzolo si entra in Marasino. Visto dall’alto, il borgo è definito da una curiosa forma stellare che si dirama dall’incrocio tra le vie Sant’Antonio, Ronco, Campicelli, Boschetti; sono i principali assi di connessione tra il borgo e l’intorno, ma il percorso “matrice” storico su cui esso è disposto a mezza costa è costituito dall’antica via Valeriana. La struttura aperta dell’abitato fa dubitare della possibile esistenza di mura medievali. Nella mappa del Catasto napoleonico l’attuale via Sant’Antonio, riconoscibile anche per la presenza della chiesa, è disposta lungo la connessione valeriana. Da lì lo spazio edificato si allunga verso piazza Maggiore e Distone. Altre direzioni di sviluppo portano ai mulini posti lungo la valle del Portazzolo; la vecchia strada per la Forcella di Sale risale il pendio verso Portole. Un’ulteriore direzione scende dolcemente a valle verso l’abitato di Conche; la parte iniziale corrisponde a via Ronco. Confrontando l’attuale situazione con quella registrata dal catasto napoleonico si può notare come la struttura insediativa del borgo di Marasino si sia modificata. L’edilizia, di carattere rurale, è a corte o a semi-corte. Si distinguono, per la forma allungata, il corpo edificato dell’attuale Trattoria Orazio e la costruzione a semi-corte disposta lungo la via Ronco. Essa si presume fosse costituita dalla ricorrente tipologia di casa rustica presente ovunque sul lago, con gli ampi loggiati lignei verso la parte più soleggiata e murature chiuse, con poche aperture, nella direzione opposta. Un esempio di piccolo edificio rurale non modificato nei suoi caratteri originari è ancor oggi presente non molto lontano dalla chiesa. Il nucleo centrale del borgo, oltre a ospitare qualche edificio a corte, potrebbe essere stato costituito da case “a torre”, serrate e divise da stretti ambiti. Questo tipo edilizio è proprio del periodo medioevale in cui la tipologia edilizia era costituita da due o più piani sovrapposti, connessi da scale interne in legno. A terra erano presenti magazzini o spazi di tipo rurale. Un significativo esempio è visibile a Conche. Negli anni Sessanta del ‘900 lungo le vie Boschetti, Ronzone, Ronco, si sviluppa quel tessuto edilizio a bassa densità costituito dal tipo edilizio a “villetta” che in pochi anni saturerà tutto o quasi il preesistente spazio agricolo tra i principali nuclei storici di Sale Marasino. Esso si è mantenuto tuttavia su un livello qualitativo discreto sia per l’edilizia sia per i giardini privati, in cui sopravvive un tessuto frammisto di ulivi che rende qualitativamente interessante l’ambiente urbano. Da Marasino una strada vicinale connetteva direttamente Gandizzano, a monte, con il palazzo Martinengo al Portazzolo, edificio tardo-rinascimentale sulla riva del lago. Questa direzionalità diretta apre interrogativi per ora non risolti sul rapporto tra palazzo e borgo, mentre ipotesi più probabili legano il primo al santuario di Santa Maria della Neve a Gandizzano, possibile cappella gentilizia, dove è presente il sepolcro “de Martinenghis”. Più in basso, a mezza costa è situato il borgo di Riva, piccola contrada agricola di probabile origine medievale circondata dai terrazzamenti degli uliveti. Non è presente una chiesa ma solo una grande cappella aperta sulla strada con lacerti di modesti affreschi. Da Marasino un altro percorso, oggi assorbito per la maggior parte delle proprietà private, scendeva verso il piccolo nucleo di Conche. La posizione del borgo risulta baricentrica agli abitati di Sale e Marasino. Le origini sono sicuramente medioevali, anche se l’ipotesi di insediamenti romani non è remota; durante gli scavi per la sistemazione del sagrato di San Giovanni Battista, nel 1959, furono rinvenute due tombe barbariche senza corredo. L’abitato presenta una struttura circolare con stretti vicoli che si intersecano creando una ramificata rete viaria. Alcune abitazioni presentano ancora parti di muratura medioevale, mentre altre tracce murarie fanno presumere l’esistenza di una cinta muraria. Il tessuto edificato è costituito da case a corte di piccole e medie dimensioni a carattere agricolo residenziale. Di particolare rilievo sono le case Antonioli (secolo XVII) e Faccoli. La prima, descritta nell’Estimo del 1706, mostra un prospetto interno con porticato sul lato sud formato da cinque archi a tutto sesto poggianti su colonne doriche, in pietra di Sarnico. Anche casa Faccoli, a ridosso della chiesa, ha un portico a cinque archi ribassati poggianti su colonne doriche in pietra di Sarnico con volte a crociera; sulla parete sud esisteva una piccola nicchia con dipinta la Vergine in gloria. Nello stesso Estimo si fa menzione di un porto in Conche, probabilmente nella zona tra Palazzo Martinengo e la chiesa dei Disciplini presso il Curetto. Da Marasino, procedendo in piano, la Valeriana raggiunge il ponte sul torrente Vigolo e il piccolo abitato di Distone, a mezza costa, ancora caratterizzato da edilizia storica di origine agricola. Da qui la strada prosegue, in un ambito paesaggistico straordinario per ampiezza e qualità, verso il nucleo di Massenzano, ultimo abitato prima del confine con Marone attraversando i borghi del Dosso e della Valle. Il primo è costituito da un gruppo di case disposte su un crinale, a poca distanza da un’antica cava di tufo (località Tufo). Da qui si articolano il corso d’acqua chiamato la Valle e l’omonimo borgo lineare. La Valle alimentava fino alla seconda metà dell’Ottocento numerosi mulini ad acqua che fornivano energia a macchinari per la lavorazione della lana, in particolare per le coperte. Il Carebbio, incrocio di vie, presenta una struttura insediativa di carattere medievale. Ospitava nel Cinquecento numerose fucine, alimentate dalla sorgente del Tufo. Oggi sono presenti alcuni bei portali risalenti ai secoli XIII-XIV. Attraverso la stretta e tortuosa via Balzerina si scende a Sale, il cui sviluppo urbano ebbe luogo nel XV e XVII secolo con la costruzione di palazzi signorili. Tra questi spiccano ancora per importanza architettonica e decorativa il quattrocentesco palazzo Averoldi-Dossi, ora Giugni (secoli XV-XVI), casa Dossi-Mazzucchelli (1560), casa Fenaroli (secoli XVI), casa Turla-Tacchini. Notevole per importanza storica è il complesso costituito dalla parrocchiale dell’Assunta e di San Zenone, dalla Pieve e dalla casa canonica, collegate dal sagrato, frutto di una stratificazione storica millenaria, originata dalla pieve di Vallis Renovata di grande importanza per tutto il comprensorio sebino-bresciano. Fabrizio Zanni, Antonio Burlotti