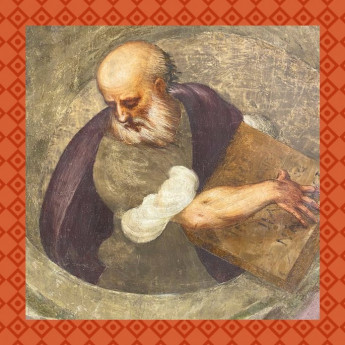Le Chiese
Diverse sono le Chiese di Brescia: SAN FAUSTINO IN RIPOSO – VIA MUSEIPassa quasi inosservata, ma in realtà è un piccolissimo gioiello nel cuore di Brescia: l’interno circolare è stato rifatto nei secoli XVIII-XIX, mentre la facciata esterna della chiesa presenta un tetto conico in cotto visibile dalla piazzetta retrostante.Il nome della chiesa deriva da un’antica leggenda e fa riferimento ad una sosta fatta proprio dove sorge la chiesa dalla processione che, all’inizio del sec. IX, trasportava i corpi dei santi Faustino e Giovita a San Faustino Maggiore. I due corpi compirono il miracolo di trasudare sangue e, in segno di devozione, la cittadinanza eresse questa cappella. SAN FRANCESCO D’ASSISI – VIA SAN FRANCESCOIl complesso dedicato a San Francesco risale al Duecento e fu ampliato tra il 1300 e il 1400, periodo in cui furono aggiunte le cappelle laterali, il presbiterio e il chiostro.Dell’edificio originario restano la facciata romanico-gotica a capanna in medolo, un particolare tipo di roccia, e la parete occidentale.Il campanile risale alla fine del 1200 e presenta bifore romaniche e, nel registro superiore, gotiche. All’interno, sul lato destro, si notano i resti dell’originaria decorazione a fresco medievale risalente ai primi anni del 1300: in particolare, le scene di un Giudizio Universale, una Pietà le cui linee si ispirano a Giotto e una Scuola di Teologia che ricorda l’attività d’insegnamento esercitata dai frati.Pregevoli i dipinti del Moretto e del Romanino, i due grandi interpreti del Rinascimento Bresciano, e quelli di Pietro Rosa, Francesco di Prato da Caravaggio, Pietro Avogadro, Pier Maria Bagnadore, Angelo Paglia, Francesco Maffei, Ottavio Amigoni, Pietro Ricchi detto il Lucchese e Giuseppe Tortelli. L’altare maggiore, del 1480 circa, è in marmo e la sua costruzione è attribuita al Tamagnino da Porlezza. L’abside poligonale a ombrello contiene affreschi d’inizio ‘500, probabilmente del bresciano Andrea Bembo.Il coro di 22 stalli lignei, con tarsie geometriche impreziosite con madreperle, è opera probabilmente di Filippo Morari da Soresina (1493).La cappella dell’Immacolata, al centro della navata sinistra, mostra una ridondante balaustra marmorea policroma ed è la più grande. Fu affrescata da Giambattista Sassi e Antonio Cucchi dopo il rifacimento architettonico Settecentesco; gli stalli intarsiati dai Virchi risalgono al 1548-1553. Nell’altra cappella si trova la tavola del Crocifisso, prezioso dipinto lombardo del 1350 inserito in una cornice Seicentesca. Dal chiostro gotico-lombardo in cotto e in pietra, opera del 1393 di Guglielmo Frizzoni da Campione, si accede alla sala capitolare, sormontata da un soffitto composto da otto spicchi in forma di stella, dove affiorano resti di affreschi del ‘300-’500.Dalla sacrestia si passa al quattrocentesco Chiostro della Madonna. SAN GIOVANNI EVANGELISTA – CONTRADA SAN GIOVANNIDi antichissime origini, la chiesa fu rifatta nel 1440 e fortemente rimaneggiata nel ‘600. Della struttura originaria permangonola facciata, con due archi ogivali, resti di tombe nobili e l’abside. All’interno si vedono solo tre delle cinque navate originarie adornate con dipinti di Antonio Gandino, Grazio Cossali, Francesco Paglia, Angelo Everardi detto il Fiammingo, Enrico Albrici, Giuseppe Nuvoloni e Francesco Raibolini.Nella sacrestia si trova un ritratto di prelato attribuito a Giacomo Ceruti detto il Pitocchetto. Il Moretto è presente con varie opere, ma soprattutto con le 11 tele della cappella del Santissimo Sacramento, contrapposte ad altrettante del Romanino.Dal fondo della navata sinistra si accede alla cappella di Santa Maria, che ospita affreschi di fine ‘400 attribuiti a Paolo da Caylina il Giovane e a Floriano Ferramola. Nel battistero si trova uno Sposalizio della Vergine del Romanino.Molto bello è anche il chiostro risalente al 1487, con un loggiato di colonne sormontate da eleganti capitelli e cornici in cotto. SANTA MARIA DELLE GRAZIE – VIA GRAZIEIl portale in pietra scolpita e i battenti in legno, probabilmente realizzati da Filippo Morari da Soresina intorno al 1490, colpiscono immediatamente il visitatore.La sobria facciata Rinascimentale si contrappone alla ricchezza del Barocco dell’interno: la decorazione a stucchi e affreschi su 350 riquadri è di grande effetto.Sulla volta della navata centrale ci sono affreschi di Francesco Giugno, ma la chiesa contiene anche dipinti di Pietro Rosa, Palma il Giovane, Moretto, Bagnadore, Grazio Cossali, Fiammenghino, frà Tiburzio Baldini, Antonio Paglia, e Paolo da Caylina.Il chiostro si regge su colonne di stile ionico e su alti piedistalli, e al centro si trova una piccola fontana con una scultura in bronzo della Madonna realizzata da Sante Calegari; alle pareti sono appesi numerosi ex voto. Il Santuario, che si trova sul lato ovest del chiostro, è stato edificato sopra le rovine della chiesa Duecentesca degli Umiliati. Fu ricostruito nel 1876 dall’architetto Antonio Tagliaferri in stile quattrocentesco e affrescato da Modesto Faustini e Cesare Bertolotti. SAN CLEMENTE – VICOLO SAN CLEMENTEL’antichissima chiesa fu modificata nel ‘400 e nel ‘600 e internamente trasformata nel 1840 da Rodolfo Vantini, ingegnere e architetto bresciano.Al suo interno si trovano numerose opere del Moretto, che abitava poco distante, e preziose tele del Romanino e di Benedetto Mora, affreschi del Foppa e Lattanzio Gambara e un Crocifisso ligneo di Jacopo Medici. Nella cappella del Rosario, adornata dagli affreschi di Pietro Zaist, si trova un altare marmoreo di Antonio Calegari. SANTI NAZARO E CELSO – CORSO MATTEOTTICostruita tra il 1752 e il 1780 su progetto di Giuseppe Zinelli e Antonio Marchetti, la chiesa ha un’imponente facciata, resa ancora più evidente dalle colonne corinzie che reggono il timpano triangolare e dalla balaustra. Le sette sculture di marmo che sovrastano la facciata sono opera dell’artista Citterio. Nel vestibolo vi sono frammenti del monumento sepolcrale di Altobello Averoldi, risalente al 1522, e due ante d’organo dipinte da Paolo da Caylina il Giovane.In corrispondenza degli altari laterali si trovano dipinti di Moretto, Antonio Gandino, Giovan Battista Pittoni, Antonio Zanchi, Giuseppe Tortelli e sculture di Antonio Calegari.All’interno della sacrestia merita la visita una Adorazione dei Magi realizzata dal Romanino su ante d’organo e un Trittico attribuito a Paolo da Caylina il Vecchio. Sul fondo del presbiterio è visibile il Polittico Averoldi, opera giovanile di Tiziano perfettamente restaurata. La pala è contenuta in una cornice marmorea realizzata dal Vantini. Accanto alla porta laterale sinistra si trovano i cenotafi dei vescovi Riario e Ducco e di Maffeo Olivieri. Annessa alla chiesa è la Canonica, con affreschi di Floriano Ferramola. SANTA MARIA DEI MIRACOLI – CORSO MARTIRI DELLA LIBERTÀLa chiesa di Santa Maria dei Miracoli fu eretta a fine ‘400, e fortunatamente è rimasta indenne alle bombe dell’ultima Guerra, che hanno distrutto l’area adiacente.La decorazione scultorea della facciata è un autentico capolavoro del Rinascimento Bresciano: ad opera di Giangasparo Pedoni, è in marmo di Botticino alternato a marmi di altre tonalità. Nel ‘500 la chiesa subì alcuni restauri operati da vari architetti che apportarono, ciascuno, la propria sensibilità: dopo Mastro Jacopo operarono il Lamberti, Girolamo da San Pellegrino, Lodovico Beretta, Giovan Maria Piantavigna e Jacopo Fostinelli da Bornato. Nel ‘700 vennero completate le cupole. L’interno è a pianta quadrata e contiene sculture di Gaspare da Coirano e Antonio della Porta. Vi sono dipinti di Bagnadore, Tomaso Bona, Pietro Marone, Grazio Cossali, Domenico Romani, Enrico Albricci e Francesco Giugno. SANT’ AGATA – CORSETTO SANT’ AGATAAnche questa chiesa è di antica origine. Fu ampliata nel 1458, gettando un ponte sulle acque del fiume Garza per ricavare l’area dove si trova il presbiterio, e nel corso degli anni ha subito numerosi rimaneggiamenti. Fra gli altri, nel ‘700 è stata aggiunta una cornice sopra il portale, coronata da statue di Antonio Calegari. Notevole è la decorazione in terracotta policroma che si trova all’esterno dell’abside.All’interno vi sono affreschi di Pompeo Ghitti, Pietro Antonio Sorisene, Pietro Marone e Pietro Avogadro. Contiene tele di Antonio Gandino, Marco Richiedei, Ottavio Amigoni, Antonio Pellegrini, Giuseppe Tortelli, Sante Cattaneo e Pietro Marone, la cui Crocifissione è conservata in sacrestia. A lato dell’ingresso della sacrestia si nota una Deposizione in marmo, risalente alla metà del Quattrocento. SAN ZENO IN FORO – PIAZZA DEL FORODell’originaria chiesa di San Zeno resta solo l’abside poligonale in cotto risalente al sec.XII, poichè intorno al 1745 il resto della struttura venne ricostruito.L’edificio è preceduto da un breve sagrato cinto da una elegante cancellata in ferro, intervallata da pilastri marmorei sormontati da putti e coppie di delfini attorcigliati.L’interno ha una navata sola e ai suoi lati sono situate quattro cappelle contenenti, ciascuna, una tela dipinta da Antonio Paglia nel 1741. L’altare maggiore, su cui s’innalza un prezioso tabernacolo arricchito da lapislazzuli e pietre di raro valore, è abbracciato da una sottile ed elaborata balaustra in ferro battuto. Gli stalli del coro, ovvero gli scranni dove sedevano i prelati, risalgono al XVIII secolo. SANT’ AFRA IN S.EUFEMIA – CORSO MAGENTALa chiesa fu ricostruita nel 1460 dai monaci Benedettini e nel primo ‘500 nel convento che si trovava al suo interno risiedeva Teofilo Folengo, umanista e monaco Benedettino.L’edificio attuale è opera dell’architetto Domenico Carboni.Nel 1774 il monaco Pietro Faita ampliò il presbiterio e restaurò l’antica cripta; la facciata marmorea è del 1776. L’interno ha una sola navata con tre cappelle per lato ricavate nello spessore della parete.Nella volta vi sono finte architetture realizzate da Pietro Ferrari e Antonio Grassi, con tre medaglioni dipinti dall’artista Sante Cattaneo.Sant’Afra ospita dipinti del Veronese, Palma il Giovane, Camillo Rama, Pietro Moro, Pompeo Ghitti ed Enea Salmeggia. La sacrestia è ricavata all’interno di una cappella gotica; nella cripta ci sono tracce di affreschi quattrocenteschi e, sulla scala, un frammento di affresco raffigurante la Madonna attribuito a Vincenzo Civerchio.Il transetto e il presbiterio sono ornati da affreschi di Carlo Carloni, all’interno di quadrature di Antonio Massa. Le cantorie lignee, ovvero il palco che veniva riservato ai coristi o cantori e che spesso formava un tutt’uno con l’organo, è del Facchetti e risale al 1540. L’altare maggiore, che contiene l’urna di San Paterio, è opera di Antonio Calegari. Il coro ligneo è stato realizzato dai fratelli Montanino e risale al ‘600. SANT’ ANGELA MERICI – VIA CRISPICostante il susseguirsi di nomi attribuiti a questa chiesa: dapprima, nel luogo dove furono inumati i primi martiri cristiani, anticamente sorgeva la cappella di San Faustino ad sanguinem; in seguito la chiesa fu ampliata e nel ‘200 divenne Sant’Afra, ovvero la chiesa, attualmente sotterranea e ricostituita in cemento armato, alla quale nel 1580 Pier Maria Bagnadore sovrappose un nuovo tempio, distrutto dai bombardamenti del 1945 e poi ricostruito con la nuova dedica a Sant’Angela. La chiesa ospita un polittico di Paolo da Caylina il Giovane e dipinti cinquecenteschi di Vincenzo Civerchio, Francesco da Ponte detto il Bassano, Bartolomeo Passarotti, Bagnadore, Pietro Marone, Carlo Caliari, oltre alla Trasfigurazione di Tintoretto.Ai primi anni del 1600 risalgono le tele di Giacomo Barucco, Giulio Cesare Procaccini e Palma il Giovane. SANTA MARIA DEL CARMINE – VICOLO MANZONEFu edificata tra il 1429 e il 1475 e rimaneggiata nei sec. XVI-XVII.Sulla facciata di stile romanico – gotico spicca l’impronta rinascimentale dei finestroni, la cui cornice è in terracotta policroma, e del portale finemente scolpito, con lunettone centrale affrescato con una Annunciazione di Floriano Ferramola. Da via San Faustino si ammira la fuga di pinnacoli che caratterizza il profilo della chiesa.All’interno si trovano pregevoli affreschi di Tomaso Sandrini, Bernardino Gandino, Camillo Rama, Antonio Gandino il Vecchio e Giacomo Barucco. Nella chiesa vi sono anche dipinti di Vincenzo Foppa, Pietro Marone, Antonio Cappello, Francesco Giugno, Bagnadore e Palma il Giovane. La settima cappella fu trasformata in sacrestia e conserva elementi architettonici originari, oltre ad ospitare affreschi del sec. XV; la cappella di sinistra ospita il gruppo ligneo quattrocentesco della Pietà, attribuito a Guido Mazzoni.L’organo è un Antenati della metà del 1500. Sulla parete di fondo della chiesa si nota la grande tela dell’Annunciazione di Pietro de Witte, detto il Candido. Un monumentale altare accoglie la piccola, ma assai venerata immagine della Madonna delle Brine, attribuita, secondo una leggenda, all’evangelista Luca. Dal cortiletto che si trova dietro l’abside si accede a una cappella affrescata da Ferramola e da Vincenzo Civerchio.I tre chiostri, il piccolo e quello maggiore risalenti al ‘400 e quello meridionale del ‘500 sono visitabili entrando da vicolo dell’Anguilla 8.